|
 |

Università degli Studi di
Napoli Federico II
Dipartimento di Studi
umanistici
Sezione di Filologia moderna:
italianistica, letterature europee e linguistica
I
nostri antenati
|
Vittorio Imbria ni
(Napoli,
1840 - Pomigliano d’Arco, 1886)
Dal
1863 al 1866, e saltuariamente in anni successivi, tiene all’Università di Napoli corsi liberi di estetica e di letteratura
tedesca come professore privato, nel 1872 un corso sulla poesia popolare italiana, dal 1872 al 1878
corsi danteschi; nel 1884 è chiamato
sulla cattedra di Estetica, ma deve rinunciare per le sue condizioni di salute
Michele Lenzi, Ritratto di V. I., 1885
(Napoli, Museo di San Martino)
|
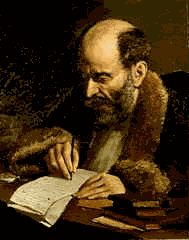 |
|
A nove anni segue il padre Paolo Emilio, liberale
condannato a morte in contumacia, in esilio a Nizza e poi a Torino: qui
conosce De Sanctis, di cui frequenta le lezioni. Continua gli studi a
Zurigo, ancora con De Sanctis, e a Berlino, dove la lettura di Hegel lo
trasforma in un monarchico assolutista: inevitabile la rottura con il
maestro e il conflitto con il padre, da cui dipenderà economicamente fino a
una dozzina di anni prima della morte. Tornato a Napoli dopo un soggiorno a
Parigi, lavora come giornalista e comincia una confusa carriera accademica,
tenendo corsi liberi di estetica, di letteratura tedesca e di letteratura
italiana. Nel 1866 partecipa come garibaldino alla terza guerra di
indipendenza, ma alla battaglia di Bazzecca è catturato e trascorre una
breve prigionia in Croazia. Conosce intanto a Gallarate, dove è di stanza il
suo battaglione, la nobildonna Eleonora Bertini, separata in casa dal marito
Luigi Rosnati, e ne diventa l’amante. Stabilitosi a Pomigliano d’Arco, in
una proprietà finalmente elargitagli dal padre, continua a frequentare
l’amante e fa da precettore, anche per via epistolare, alle sue due figlie,
finché, nel 1878, la lascia per sposarne la figlia più piccola. Gli ultimi
anni sono segnati da una malattia che lo renderà paralitico e da una
scottante sconfitta accademica: la cattedra di Letteratura italiana, che era
stata di Settembrini, gli viene negata (e assegnata invece a Zumbini) da una
commissione che Imbriani riteneva ostile, avendo ridicolizzato in alcuni
scritti le opere di due dei cinque commissari (Aleardi e Zanella). Nel 1884,
alla morte di Antonio Tari, è chiamato sulla cattedra di Estetica, ma non
può tenere nemmeno una lezione per la sua grave invalidità. Si spegne il 1°
gennaio 1886.
Narratore di fisionomia espressionistica, in
particolare con i romanzi Merope IV (1867) e Dio ne scampi dagli
Orsenigo (1876), poeta
sperimentatore di metri neoclassici di tipo oraziano, Vittorio
Imbriani, «bizzarro ingegno» secondo Alessandro D’Ancona, riabilitato
autorevolmente nel Novecento da Croce e da Contini, fu un irregolare anche
come studioso. I suoi interessi spaziano dalla «demopsicologia» (termine da
lui creato e poi ripreso dall’antropologo Giuseppe Pitré), consistente, in
sostanza, nello studio dei canti e della narrativa popolare (fiabe,
racconti), di cui fu instancabile raccoglitore e ‘stenografo’ (con un
eccesso di fedeltà che gli fu rinfacciato proprio dai filologi), alla
critica militante e a una vulcanica attività giornalistica (fu tra l’altro
direttore del quotidiano La Patria) fino
all’erudizione delle ricerche dantesche (si deve a lui l’etichetta di «rime
petrose»). Queste furono avviate dopo una ventennale astinenza da Dante
seguita alla diligente acribia con la quale negli anni 1854-55 aveva frequentato il corso
dantesco tenuto da De Sanctis a Torino nel Collegio San Francesco di Paola: una sorta di periodo di decantazione, innescato dalla
rottura con il venerato maestro, che sfociò nell’elaborazione, in ambito
dantesco, di un metodo critico che ribaltava quello estetico desanctisiano.
Quest’ultimo, come si sa, considera la creazione poetica quasi un blocco
compatto, un organismo vivo, che il critico ricrea in sé ripercorrendone lo
sviluppo datogli dal poeta, e prescindendo dai contenuti astratti (le
situazioni politiche, sociali, morali, culturali, ecc.). Per Imbriani, al
contrario, la forma dantesca è uno schermo trasparente il cui godimento
estetico è subordinato alla possibilità di recupero dei contenuti astratti,
e neanche dei più elevati, bensì di quelli afferenti alla sfera della
psicologia e dell’esistenza quotidiana. I suoi studi danteschi, tuttavia,
per l’eccesso di polemica che animò le sue recensioni (soprattutto quella
sull’esilio di Dante di Isidoro Del Lungo del 1881), furono dapprima
boicottati e successivamente rigettati dal dantismo ufficiale: l’atto di
morte fu vergato da Renier nel 1891 con una stroncatura impietosa e
liquidatoria.
Bibliografia essenziale. — Dell’organismo poetico e della poesia popolare
italiana. Sunto delle lezioni dettate nei mesi di febbraio e marzo 1866
nella Regia Università Napoletana, Napoli 1866; Canti popolari delle
provincie meridionali, raccolti da Antonio Casetti e V. I., 3 voll.,
Torino 1871-1872; XII conti pomiglianesi, illustrati da V. I., Napoli
1876; La novellaja fiorentina: fiabe e novelline stenografate
in Firenze dal dettato popolare da V. I., Livorno 1877; Fame
usurpate. Quattro studii, Napoli 1877; Appunti critici, Napoli
1878; Sulle canzoni pietrose di Dante, Bologna 1882; Epicedii del
Kant [traduzioni commentate di testi in versi di Kant], Napoli 1884;
Studi danteschi, Firenze 1891; Studi letterari e bizzarrie satiriche,
a cura di B. Croce, Bari 1907; Critica d’arte e prose narrative, a
cura di G. Doria, Bari 1937; Carteggi di Vittorio Imbriani, a cura di
N. Coppola, 3 voll., Roma 1963-1965. ~
Opere in rete
(anche gli
Epicedii,
i romanzi ecc.).
[A. Fratta]
|
Indice dei nomi
Indice
cronologico
Indice per
discipline |
11.5.2011 |