|
 |

Università degli Studi di
Napoli Federico II
Dipartimento di Studi
umanistici
Sezione di Filologia moderna:
italianistica, letterature europee e linguistica
I
nostri antenati
|
Guido Manacorda
( Acqui
[Alessandria], 1879 - Firenze, 1965)
Dal 1906 bibliotecario, poi direttore, della Biblioteca
Universitaria di Catania, dal 1911 di quella di Pisa; professore di
Lingua e letteratura
tedesca all’Università di Napoli dal 1913 al 1925 (dal 1915 al 1918
in guerra volontario), quindi all’Università di Firenze fino al 1946,
quando fu rimosso dall’insegnamento e collocato anticipatamente
a riposo per la sua stretta collaborazione, ai più alti livelli, con il fascismo e con il nazismo |
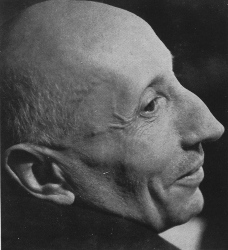 |
|
Si laurea
in letteratura italiana all’Università di Pisa e si perfeziona a Firenze e in Germania. Professore
di Lingua e letteratura tedesca dal 1913 all’Università di Napoli, nel 1915
si arruola volontario e torna dalla Grande Guerra pluridecorato, dopo essere
stato a capo della formazione di arditi La Giovane Italia. Verso i
quarant’anni è colto da una crisi mistica. Si fa intanto conoscere da
Mussolini e ne diventa una sorta di ambasciatore free lance: in
particolare fu suo emissario di fiducia presso Hitler, che incontrò più
volte a partire dal 1936; agì anche da informatore e consulente della Santa Sede nel
corso dei difficili rapporti di quest’ultima con il Terzo Reich. Sulla
questione razziale assunse un atteggiamento in parte critico, ma
comunque ambiguo; strinse inoltre rapporti con i cattolici antisemiti
tedeschi. In un primo momento, i suoi interessi scientifici
si concentrano sulla filologia (anche germanica), la bibliografia e
l’erudizione letteraria, tanto da fondare nel 1908 la rivista Studi di
filologia moderna, che guida fino al 1914. A Firenze dal 1925, dirige
per la Sansoni una collana di classici stranieri (la cura di un’altra
collana simile gli era stata affidata da Laterza negli anni dieci). Intorno
al 1920 comincia a interessarsi a Wagner, di cui tradurrà, in quindici anni,
l’intera opera drammatica, riveduta nel testo e rigorosamente annotata: edizione che
resta forse il suo capolavoro di studioso. Alla critica di Croce alla sua
traduzione del Faust di Goethe (1932) rispose con un opuscolo
violentemente polemico. Allontanato dall’insegnamento nel 1946, torna a
coltivare nuove iniziative editoriali (crea la raffinata collana «Il
melograno» per l’editore Fussi di Firenze) e si dedica quasi esclusivamente
alla scrittura religiosa.
Bibliografia essenziale [dei soli scritti letterari]. Benedetto Varchi,
Pisa 1903 (tesi di laurea; estratto dagli Annali della R. Scuola Normale
Superiore di Pisa, vol. XVII); Germania
filologica. Guida bibliografica per gli studiosi e per gl’insegnanti di
lingua e letteratura tedesca, Cremona 1909;
J. W. Goethe, Le elegie, le epistole e gli epigrammi veneziani,
testo, versione e commento a cura di G. M., Firenze 1921; I drammi
di Riccardo Wagner, riveduti nel testo con versione ritmica italiana a
fronte, introduzione e commento a cura di G. M., 11 voll., Firenze
1921-1936; Studi e saggi,
Firenze 1922;
J. W. Goethe, Il Faust, versione integra dell’edizione critica di
Weimar, a cura di G. M., Milano 1932; Benedetto Croce, ovvero
Dell’improntitudine, Firenze 1932; La selva e il tempio. Studi sullo
spirito del germanesimo, Firenze 1933; Walther von der Vogelweide,
Canti, a cura di G. M., Firenze 1947. ~
Opere in rete.
[U.
Böhmel]
|
Indice dei nomi
Indice
cronologico
Indice per
discipline |
23.5.2011 |